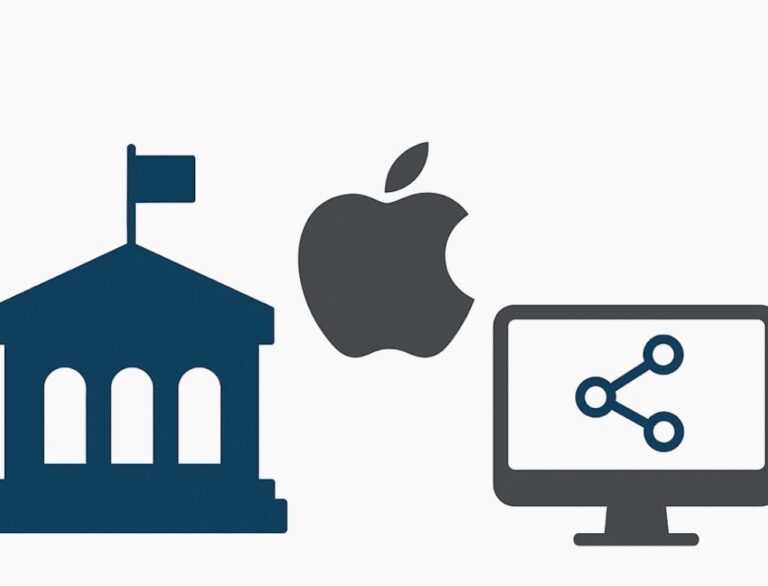
L’intervento pubblico nell’economia vive una nuova vita nell’ambito della trasformazione digitale. Qualche esempio storico consente di inquadrare il momento attuale e osservare le differenze delle scelte compiute dagli Stati. È quanto avviene con i casi di Spagna e Italia che, pur inseriti nel percorso comune dell’Unione europea, presentano strumenti, organizzazioni e obiettivi molto differenti. Un segno della perdurante vitalità delle scelte pubbliche e della pluralità dei modelli cui guardare.
L’intervento pubblico nell’economia non rappresenta un elemento caratteristico di risposta alle crisi dell’ultimo ventennio. O, meglio, anche ai fini che ci occupano, possiamo osservare come l’intervento pubblico dell’economia non possa essere limitato ad una mera funzione di sostegno – spesso, salvataggio – in risposta alle crisi. Al contrario, è stato osservato come esso costituisca un’attribuzione fondamentale dei pubblici poteri che acquista maggior rilevanza con l’espansione delle funzioni pubbliche: non costituisce, pertanto, una vicenda caratterizzante del nostro tempo.
Tale intervento non ha mai assunto caratteri omogenei ma, al contrario, ha sempre assunto forme differenti per il perseguimento di obiettivi differenti: si pensi, ad esempio, al passaggio dallo Stato imprenditore allo Stato regolatore, manifestazione dell’evoluzione – registrata dalla fase di gestione statale diretta di alcuni settori economici – alla fase di regolazione di quegli stessi settori (parla di “equilibrio dinamico” tra regolazione e innovazione la Prof.ssa Luisa Torchia in un precedente editoriale dell’Osservatorio Stato Digitale)
Concentrando l’attenzione sugli incentivi all’innovazione delle tecnologie digitali e, con essi, allo sviluppo dell’imprenditoria privata, gli effetti appaiono duplici: da un lato, si producono verso il comparto e gli operatori; dall’altro lato, interessano di riflesso anche l’azione pubblica, nelle forme della cd. amministrazione digitale.
Ciò conduce alla creazione e allo sviluppo di determinati mercati a discapito di altri e una sorte diversa delle posizioni dei relativi operatori: è lo Stato a decidere “chi vince e chi perde” (The Economist, 2012), spesso senza averne le competenze adeguate, ragione per la quale tale tipologia di intervento non ha mai incontrato il favore degli economisti.
Questa dinamica pone pesanti interrogativi, ancor oggi.
Sul punto, tuttavia, non mancano esempi positivi, anche di rilievo internazionale. È il caso degli interventi pubblici alla base della rivoluzione tecnologica che ha portato alla realizzazione dei prodotti all’avanguardia della Apple e, con essi, di un nuovo mercato di rilevanza mondiale. La Apple, infatti, oltre a ricevere investimenti diretti nel capitale ed altre agevolazioni economiche, ha potuto avere accesso a tecnologie sviluppate mediante programmi di ricerca pubblici. Se si considerano le tecnologie alla base dell’iPhone, si evidenzia che il touch-screen era frutto di una ricerca universitaria finanziata dallo Stato; lo stesso vale per Internet (Arpa, e, poi, Darpa); GPS e Siri (tecnologie ad uso militare); schermo a cristalli liquidi, disco rigido, microprocessore e chip di memoria (tecnologie sviluppate durante la guerra fredda). Di segno analogo è il dibattitto sul governo delle infrastrutture digitali (come aveva osservato il Dott. Luca Golisano)
L’intervento pubblico con funzioni di sviluppo dell’innovazione consente altresì di imprimere una direzione mission-oriented allo sviluppo economico e al progresso tecnico, come nel caso delle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici, di cui l’Unione europea si fa promotrice.
In materia si osserva il coinvolgimento di un numero sempre maggiore di soggetti pubblici, determinando l’estensione del perimetro delle pubbliche amministrazioni. È il fenomeno, ad esempio, in forza del quale si assiste, nel contesto nazionale, a un ruolo fondamentale svolto dalle società a partecipazione pubblica per la gestione degli interventi diretti mediante contributi e agevolazioni alle imprese.
Queste indicazioni di massima devono essere applicate nell’ambito dello sviluppo delle tecnologie digitali e, in particolare, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, anche note con l’acronimo ICT, per mezzo delle quali è stato possibile raccogliere una vasta quantità di dati e informazioni da rielaborare per l’individuazione di inedite forme di sfruttamento, di cui l’intelligenza artificiale, per citare l’esempio più lampante, costituisce solo l’ultimo esempio.
In questo contesto, l’Unione europea ricopre un ruolo centrale per incentivare l’utilizzo e la domanda di dati e prodotti e servizi basati sui dati in tutto il mercato unico, come testimoniano le iniziative assunte a partire dall’adozione della Data Strategy (2020). La traduzione concreta di tali indicazioni è però rimessa ai singoli Stati, ragione per la quale l’intervento pubblico in economia si rivolge, con modi e forme differenti, allo sviluppo delle tecnologie digitali. A livello nazionale, ad esempio, si prediligono interventi diretti nell’economia con agevolazioni ed incentivi basati sul livello di innovazione e gestiti tramite società pubbliche (Cassa Depositi e Prestiti, Invitalia).
Diverso è, invece, il peculiare modello spagnolo, rappresentato dalla Oficina del Dato, una struttura amministrativa creata per lo sviluppo e la diffusione delle economie basate sui dati, nei confronti tanto del settore pubblico quanto del settore privato. La Oficina del Dato è una División del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, all’interno della Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
In particolare, mediante la División Oficina del Dato si attua un intervento indiretto nell’economia con finalità di sviluppo dell’innovazione, in quanto la struttura opera tanto a livello di policy, mediante la creazione di strategie e quadri per la gestione dei dati, ovvero mediante la creazione di spazi per la condivisione dei dati tra aziende, cittadini e amministrazioni, per favorire i processi decisionali data driven; quanto a livello tecnico, mediante l’elaborazione di standard e l’individuazione delle soluzioni tecnologiche più adeguate. La Oficina del Dato non ha funzioni regolatorie, bensì di impulso e proposta nel coordinamento degli operatori, pubblici e privati, coinvolti dagli sviluppi dell’economia basata sui dati, per favorire e potenziare l’utilizzo, la condivisione e la gestione di dati con finalità economiche.
Ad esempio, la División Oficina del Dato, nel favorire lo sviluppo e la diffusione di best practises legate alla gestione dei dati, ha istituito un Grupo de Trabajo Interministerial del Dato con incontri a carattere puntuale per il confronto e lo scambio di esperienze e conoscenze sul tema.
Un modello analogo, in Italia, non è presente. Mancano, infatti, esempi di organismi pubblici con finalità di impulso e proposta, non solo “politica”, ma anche tecnica, volti a creare momenti di confronto e condivisione tra istituzioni pubbliche e operatori privati. O, meglio, analoghi poteri sono riconosciuti a specifiche autorità per la tutela di specifici interessi (privacy, antitrust e cybersicurezza, per citare quelle maggiormente coinvolte) e non vi è una visione unitaria e coordinata che possa condurre a uno sviluppo omogeneo nell’innovazione tecnologica che tenga in considerazione la pluralità di interessi rilevanti.
Diverso è il ruolo del Dipartimento per la trasformazione digitale, finalizzato alla promozione e al coordinamento delle azioni del Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie digitali. Così come diverso è il ruolo affidato all’Agid di supporto e orientamento alle amministrazioni pubbliche mediante l’adozione di norme tecniche e linee guida. Nonostante ciò, l’Agid, nella “Strategia per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione del Paese” per l’anno 2025, evidenzia la centralità del ruolo dello Stato nell’agevolare e sviluppare l’innovazione, anche mediante l’istituzione di tavoli di confronto tra pubblico e privato ritenuti “fondamentali per guidare la trasformazione del Paese verso la digitalizzazione e l’innovazione”. Anche la redazione del Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione è avvenuta grazie a un’attività di scambio e concertazione tra amministrazioni e soggetti istituzionali.
Il quadro proposto dell’intervento pubblico in economia per favorire lo sviluppo dell’innovazione rende evidente la necessità di una collaborazione simbiotica tra pubblico e privato. Ciò si deve, in particolare, al riconoscimento – come testimonia l’esempio statunitense – che l’intervento dello Stato in economia può rappresentare per lo sviluppo di realtà imprenditoriali inedite che la fornitura di incentivi diretti non avrebbe garantito. Da tale collaborazione, resa all’interno del più ampio “ecosistema” dell’innovazione, derivano uno sviluppo economico e una crescita integrata tra pubblico e privato – come testimonia l’esempio spagnolo. In tale contesto, il modello italiano rimane timidamente sullo sfondo. Da una parte l’immagine, puramente americana, di un ritorno dello Stato imprenditore, risulta di difficile attuazione a fronte di una progressiva riduzione dell’ingerenza pubblica nell’economia e, in generale, a una contestuale riduzione del potere di spesa pubblica. Sono aspetti legati al mutato contesto, all’evoluzione dell’Unione europea e unificazione dei mercati. Si pensi, infatti, alle risorse che il disegno di legge recante “Misure per la governance, la sostenibilità e lo sviluppo dell’innovazione digitale e tecnologica” (DDL 964, Legislatura XIX) propone di attribuire al “Fondo per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale” pari a “soli” 300 milioni di euro. Della dotazione finanziaria messa in campo dal governo al fine di consolidare la strategia nazionale per l’intelligenza artificiale si erano anche occupate M. Azzella e M. Monaco, Intelligenza Artificiale: la sfida del Governo. È stata poi indicato in un miliardo l’ammontare dei finanziamenti che, tramite Cassa Depositi e Prestiti ed Invitalia, dovranno stimolare gli investimenti in intelligenza artificiale. Cifre che sfigurano se comparate a quanto speso da OpenAi per lo sviluppo di ChatGPT nel corso dell’anno 2022 (540 milioni di dollari) o rispetto al complesso piano di investimenti francese (AI Booster France 2030) per un totale di 54 miliardi di euro.
Per converso, è al modello spagnolo che si dovrebbe guardare, come in radice si sta facendo: la sinergia tra pubblico e privato, anche mediante la condivisione di best practises e di conoscenza, può diventare la chiave per raggiungere risultati concreti e volano di crescita economica.
Osservatorio sullo Stato Digitale by Irpa is licensed under CC BY-NC-ND 4.0